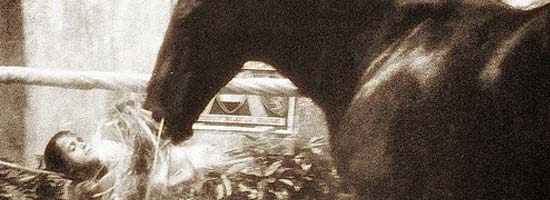Giorgio Civai. L'anima di Castelsenio

Lui aveva dieci anni esatti (era nato nel 1926) quando si aggregò a “quelli più grandi” – come eravamo noi – a Sant’Agostino. Poi c’erano altri più grandi, e ancora più grandi, in una scala che nessuno aveva fatto ma che si sentiva senza sapere perché. Allora tre anni rappresentavano gli archi della parentesi. A quelli più piccoli ci rivolgevamo sempre per fare il Palio "con i cavalli": e s'imbrigliavano con gli spaghi. Oppure si imbarcavano per lavori di "sussistenza" o di "servizi vari" come quello di andare fuori Porta Tufi a cogliere i sanguinelli (anche se noi avevamo l'orto botanico a portata di mano); per drizzare i bossoli di carta quando si giocava a "Pamela", per raccattare i palloni quando volavano giù per la piaggia fino a San Giuseppe, o per montare di guardia a Porta all'Arco per darci un segno se veniva il buon vigile Balena (che aveva sempre ragione e noi sempre torto e si scappava regolarmente, non come fanno certi cialtroncelli di oggi che vogliono mettersi a reclamare i "diritti"). Era il più bello di tutti, allegro e ingegnoso. Fu anche della squadretta, insieme ad Enzo Talluri, Mario Morelli, Aldo Tamburi, Elio Cini e Ciro Gaggiani, che tentava di riprodurre le scene di Tarzan con le vitalbe, in fondo al bosco dell'orto botanico. E ci usciva quasi sempre il ginocchio malconcio. Avevamo formato anche una squadra di calcio (quelli del Senio erano merce scelta) e d'inverno si giocava con quelli della Chiocciola (una volta a Sant'Agostino e una volta nel piazzalone davanti alla Porta San Marco), con quelli dell'Aquila (al "pallone" sotto Fortezza) o con quelli dell'Onda al Mercato. C'erano anche Guido Cencini, Ferodo Bianchi, Bruno Burroni, Vasco Stanghellini, Eraldo Baldi, Danilo Pepi: tutti della Tartuca. Alvaro Minucci della Pantera, Ilio Bruni e Mimmi Iannone della Chiocciola, Irio Sbardellati dell'Onda, Sergio Cardascia dell'Aquila. Ma di anni sono passati troppi e allora il "diario" della Contrada non lo tenevo: diversi nomi possono saltare.
 Lui stava venendo fuori con i disegni, recitava a Castelsenio, si dava tanto daffare per la festa della Madonna dell'8 settembre. Una volta si fece nella "spiaggina" di Sant'Agostino e venne stupenda. Augusto Mazzini si commosse e ci dette perfino due braccialetti (dì quelli stretti a tavola) e due bandiere (di quelle di tela). Ma la "spiaggina" (attuale Piazzetta Silvio Gigli, ndr) , si capisce, era un angolo stupendo, e non invaso perversamente dalle macchine come oggi, con violenza, prepotenza e sensibilità da gazzillori. Invano Renato Pellizzer ha fatto mettere una catena. Qualche screanzato ha rotto il lucchetto e i "protezionisti" si sono scoraggiati (e hanno fatto male). La pendenza era proprio adatta per il Palio con i barberi. Ne avevano di belli Aldo Tamburi e Nanni Martellucci: di quelli grossi di legno, verniciati. Ma bisognava proteggerli dalla bocca spalancata della gavina dove quasi sempre erano tentati di ruzzolare (e quanti ne ha ingoiati di quelli piccoli, che si compravano dal sor Ottavio Talluri insieme alle liste di carta Lucida che, con pazienza, si ritagliavano a fettuccine e si attaccavano con la colla fatta in casa!). Con le liste si facevano anche le "pennacchiere" (che noi, sbagliando, si chiamavano spennacchiere) e gli zucchini con tanto di doppia visiera. Artigiani maestri erano, neanche a farlo apposta, proprio lui, Giorgio e Ferodo. Mi ricordo che Aldo, sempre in prima fila con tutti i giocattoli del creato, aveva un tamburo invidiabile. Credo sia stato il primo su cui Giorgio dette i colpi di mazza e provò il rullo "alla Galliano". E come gli riusciva bene! Intanto gli anni passavano e i ragazzi crescevano. Venivano sù come il grano, Boggione, Ciccio Barontini, Gino Barcelli, Luciano Chellini, Gastone Brandani, Mario Martinelli detto "Morino" Giorgio Lunetti, Luciano e Rino Bartalini (che non erano nè fratelli nè cugini). E ogni tanto spuntavano Ivo Baldi, Luciano Cocci, Renzino Bartalucci, Ivo Giachetti, Ubaldo Turillazzi, Mario Neri e Giuseppe Mazzini. La squadra era diventata uno squadrone quando scoppiò la guerra e sciupò ogni cosa. Quelli più grandi tutti sotto le armi (Dario, Gerardo, Bruno Duranti, e via di seguito). Quelli più piccoli scombinati fra la scuola, le adunate e il lungo conteggio per il Palio che mancava, per le bandiere che non si vedevano più (alle processioni e ai funerali o il paggio ai matrimoni), per la società ridotta ai minimi termini. I più coraggiosi furono reclutati per gli "spettacoli" per i feriti delle forzearmate. Il teatrino "Senio" fu la forza centipetra di noi ragazzi. Ma solo in pochi sapevano recitare. I più stavano a guardare. Ci si confondevano Carlino Arrighi e Odelisco Lambardi e il più bravo era Giorgio. Ma dietro a lui venivano bene anche Enzo Talluri e Aldo Tamburi (la cui vera professionalità la metteva nel fare il suggeritore e "imbeccare" a tempo giusto gli attori che si scordavano facilmente la parte). Furono anni duri. Si studiava a brutto allora e, d'estate, con Castelsenio chiuso (ci tornarono gli sfollati) e senza Contrada attiva, si pendolava parecchio e si cominciava a darsi le arie di giovanottelli in cerca dell'immancabile destino e, magari, di qualche citta delle suore di Sant'Anna, contentandoci di uno sguardo e litigandoci un sorriso. Tempi di sospiri. Poi i grandi marosi del '43 e del '44. Giorgio Civai partì anche lui. Andò in marina. Fummo sballottati chi a destra chi a sinistra. Ci si vedeva qualche volta con la divisa, ma non avevamo il tempo di stare insieme. Neppure per qualche breve licenza. Sussultava ogni cosa, pareva un terremoto. Anche le nostre coscienze. Fummo chiamati a delle scelte che di solito è difficile fare a qua‑rant'anni e noi ne avevamo appena diciotto o diciannove. Non c'era consiglio di babbo che decidesse. Si voleva fare da noi. E in questo la gioventù si è sempre somigliata. Fu un gioco di bussolotti, ma più di uno ci lasciò la pelle per l'"ideale". Quando ci ritrovammo avevamo tanto bisogno di sentirsi giovani, un po' vanitosi, ma sopratutto sereni. Mi pare che Giorgio arrivò in tempo per il primo Palio. Di certo fu a quello straordinario del 20 agosto 1945, perchè si vestì da paggio porta-armi. E nel 1946, fra un'indecisione e un'altra fra tamburino e alfiere, finì per vestirsi da alfiere per il giro annuale, quando ai Tufi si erano portati Mauro Bernardoni, Ilio Guideri, Adù e un paio d'altri ad imparare per bene insieme ai vecchi. Giorgio era sbocciato. Sapeva fare tutto: il"batterista" nelle orchestre, il"vetrinista", il pittore e il "cartellonista", il "presentatore" e il regista. Passò alcuni mesi fuori, tra settembre e maggio, per via del lavoro che stentava a trovare. Tornava sempre con idee nuove e pieno di buona volontà. Andò a Trieste, suo vecchio porto di mare, e nel 1951 condusse al Palio Gianna, la fidanzata. Era la prima volta e portò subito bene, perchè dopo sedici anni riuscimmo a strappare le ali alla fortuna. Mi ricordo che si trascinava dietro il suo carattere tutto sorriso ma anche leggermente schivo, tutt'altro che invadente, portato sempre alla tolleranza, in attesa di disposizioni di quelli più grandi per non parlare di quelli più vecchi del la Contrada, che - a buona ragione - si idolatrava e rispettava qualche volta anche scalpitand (senza farsi vedere). Però cominciò da allor un suo inserimento nuovo, più autonomo. Stava diventando uno dei non molti giovanotti-pilota per quelli che dovevano seguire Cominciò a scrivere le primi poesie, le prime canzonette, pe] il numero unico del 1953 feci anche un paio di vignette (cartelloni, sia nel 1951 che ne. 1953 e, dopo, nel '67 e nel '72 costituirono il suo regno, la sui pedana di lancio, la sua presentazione anche come caricaturista). Mai una volta si fosse battuto il petto. Mai una volte avesse detto "io". "Sciocchezze", diceva. E tutti, anche noi più: anziani, si ripassava a memoria l'umiltà. Lavorò dal Ceccuzzi, negli anni '56, '57 mi pare, come vetrinista in Via Montanini. De quelle parti avevo l'ufficio e la redazione de' "La Nazione". Spesso lo salutavo al di là del vetro, perchè lui era tutto proteso sopra le tavole di legno, tre lunghe pezze di stoffa di cento colori, con cento spilli sul bavero, un lapis in bocca e un righello lungo che spuntava fuori dal taschino come un periscopio. Si era già sposato ed era nato Cesare. Si era sposato anche con Castelsenio ed era divenuto un autoclave, perchè con le sue tante ingegnosità era capace di alzare anche l'acqua.
Lui stava venendo fuori con i disegni, recitava a Castelsenio, si dava tanto daffare per la festa della Madonna dell'8 settembre. Una volta si fece nella "spiaggina" di Sant'Agostino e venne stupenda. Augusto Mazzini si commosse e ci dette perfino due braccialetti (dì quelli stretti a tavola) e due bandiere (di quelle di tela). Ma la "spiaggina" (attuale Piazzetta Silvio Gigli, ndr) , si capisce, era un angolo stupendo, e non invaso perversamente dalle macchine come oggi, con violenza, prepotenza e sensibilità da gazzillori. Invano Renato Pellizzer ha fatto mettere una catena. Qualche screanzato ha rotto il lucchetto e i "protezionisti" si sono scoraggiati (e hanno fatto male). La pendenza era proprio adatta per il Palio con i barberi. Ne avevano di belli Aldo Tamburi e Nanni Martellucci: di quelli grossi di legno, verniciati. Ma bisognava proteggerli dalla bocca spalancata della gavina dove quasi sempre erano tentati di ruzzolare (e quanti ne ha ingoiati di quelli piccoli, che si compravano dal sor Ottavio Talluri insieme alle liste di carta Lucida che, con pazienza, si ritagliavano a fettuccine e si attaccavano con la colla fatta in casa!). Con le liste si facevano anche le "pennacchiere" (che noi, sbagliando, si chiamavano spennacchiere) e gli zucchini con tanto di doppia visiera. Artigiani maestri erano, neanche a farlo apposta, proprio lui, Giorgio e Ferodo. Mi ricordo che Aldo, sempre in prima fila con tutti i giocattoli del creato, aveva un tamburo invidiabile. Credo sia stato il primo su cui Giorgio dette i colpi di mazza e provò il rullo "alla Galliano". E come gli riusciva bene! Intanto gli anni passavano e i ragazzi crescevano. Venivano sù come il grano, Boggione, Ciccio Barontini, Gino Barcelli, Luciano Chellini, Gastone Brandani, Mario Martinelli detto "Morino" Giorgio Lunetti, Luciano e Rino Bartalini (che non erano nè fratelli nè cugini). E ogni tanto spuntavano Ivo Baldi, Luciano Cocci, Renzino Bartalucci, Ivo Giachetti, Ubaldo Turillazzi, Mario Neri e Giuseppe Mazzini. La squadra era diventata uno squadrone quando scoppiò la guerra e sciupò ogni cosa. Quelli più grandi tutti sotto le armi (Dario, Gerardo, Bruno Duranti, e via di seguito). Quelli più piccoli scombinati fra la scuola, le adunate e il lungo conteggio per il Palio che mancava, per le bandiere che non si vedevano più (alle processioni e ai funerali o il paggio ai matrimoni), per la società ridotta ai minimi termini. I più coraggiosi furono reclutati per gli "spettacoli" per i feriti delle forzearmate. Il teatrino "Senio" fu la forza centipetra di noi ragazzi. Ma solo in pochi sapevano recitare. I più stavano a guardare. Ci si confondevano Carlino Arrighi e Odelisco Lambardi e il più bravo era Giorgio. Ma dietro a lui venivano bene anche Enzo Talluri e Aldo Tamburi (la cui vera professionalità la metteva nel fare il suggeritore e "imbeccare" a tempo giusto gli attori che si scordavano facilmente la parte). Furono anni duri. Si studiava a brutto allora e, d'estate, con Castelsenio chiuso (ci tornarono gli sfollati) e senza Contrada attiva, si pendolava parecchio e si cominciava a darsi le arie di giovanottelli in cerca dell'immancabile destino e, magari, di qualche citta delle suore di Sant'Anna, contentandoci di uno sguardo e litigandoci un sorriso. Tempi di sospiri. Poi i grandi marosi del '43 e del '44. Giorgio Civai partì anche lui. Andò in marina. Fummo sballottati chi a destra chi a sinistra. Ci si vedeva qualche volta con la divisa, ma non avevamo il tempo di stare insieme. Neppure per qualche breve licenza. Sussultava ogni cosa, pareva un terremoto. Anche le nostre coscienze. Fummo chiamati a delle scelte che di solito è difficile fare a qua‑rant'anni e noi ne avevamo appena diciotto o diciannove. Non c'era consiglio di babbo che decidesse. Si voleva fare da noi. E in questo la gioventù si è sempre somigliata. Fu un gioco di bussolotti, ma più di uno ci lasciò la pelle per l'"ideale". Quando ci ritrovammo avevamo tanto bisogno di sentirsi giovani, un po' vanitosi, ma sopratutto sereni. Mi pare che Giorgio arrivò in tempo per il primo Palio. Di certo fu a quello straordinario del 20 agosto 1945, perchè si vestì da paggio porta-armi. E nel 1946, fra un'indecisione e un'altra fra tamburino e alfiere, finì per vestirsi da alfiere per il giro annuale, quando ai Tufi si erano portati Mauro Bernardoni, Ilio Guideri, Adù e un paio d'altri ad imparare per bene insieme ai vecchi. Giorgio era sbocciato. Sapeva fare tutto: il"batterista" nelle orchestre, il"vetrinista", il pittore e il "cartellonista", il "presentatore" e il regista. Passò alcuni mesi fuori, tra settembre e maggio, per via del lavoro che stentava a trovare. Tornava sempre con idee nuove e pieno di buona volontà. Andò a Trieste, suo vecchio porto di mare, e nel 1951 condusse al Palio Gianna, la fidanzata. Era la prima volta e portò subito bene, perchè dopo sedici anni riuscimmo a strappare le ali alla fortuna. Mi ricordo che si trascinava dietro il suo carattere tutto sorriso ma anche leggermente schivo, tutt'altro che invadente, portato sempre alla tolleranza, in attesa di disposizioni di quelli più grandi per non parlare di quelli più vecchi del la Contrada, che - a buona ragione - si idolatrava e rispettava qualche volta anche scalpitand (senza farsi vedere). Però cominciò da allor un suo inserimento nuovo, più autonomo. Stava diventando uno dei non molti giovanotti-pilota per quelli che dovevano seguire Cominciò a scrivere le primi poesie, le prime canzonette, pe] il numero unico del 1953 feci anche un paio di vignette (cartelloni, sia nel 1951 che ne. 1953 e, dopo, nel '67 e nel '72 costituirono il suo regno, la sui pedana di lancio, la sua presentazione anche come caricaturista). Mai una volta si fosse battuto il petto. Mai una volte avesse detto "io". "Sciocchezze", diceva. E tutti, anche noi più: anziani, si ripassava a memoria l'umiltà. Lavorò dal Ceccuzzi, negli anni '56, '57 mi pare, come vetrinista in Via Montanini. De quelle parti avevo l'ufficio e la redazione de' "La Nazione". Spesso lo salutavo al di là del vetro, perchè lui era tutto proteso sopra le tavole di legno, tre lunghe pezze di stoffa di cento colori, con cento spilli sul bavero, un lapis in bocca e un righello lungo che spuntava fuori dal taschino come un periscopio. Si era già sposato ed era nato Cesare. Si era sposato anche con Castelsenio ed era divenuto un autoclave, perchè con le sue tante ingegnosità era capace di alzare anche l'acqua.
 Cesare sembrò poco e venne fuori anche Gianni. I suoi figli furono la colla d'innesto con il mondo della gioventù con il quale, del resto, faceva sempre racca perchè si sentiva giovane di dentro anche se gli anni passavano senza fargli troppo male, nè togliere un capello o scavare una piccola ruga. Il suo era un temperamento di quelli che se fossero in vendita farebbero la fortuna dello spacciatore. Ottimista, rigoglioso, non stava però ad aspettare la manna dal cielo. Quando aveva un'idea ci si baloccava, cercava di ravversarla per benino, restava in forse qualche tempo (perchè era un amante del perfezionismo fino allo scrupolo), eppoi si lanciava e allora nessuno gli teneva dietro. Fra tante cose che sapeva fare, fra le tante sue passioni, c'era la gastronomia. Divideva volentieri il fardello con Nirvano Fossi, tra una battuta e un'altra, tra un frizzo e un altro, e tirava fuori certi risultati che qualche locale rinomato davvero se li sognava (e se li sogna). Vennero fuori quasi per scherzo, tutti i due, quando cominciarono i lavori per la ristrutturazione di Castelsenio e tutta la cucina era in un paio di bracieri, qualche pentolona e il chiassino con il cielo per soffitto. Incominciarono allora i "venerdì". Alla fine di ogni serata, stanchi, sudati e allegri, si arrotolavano il grembiule alla bella maniera, si sedevano a un pinzo della lunga tavola, Nirvano con la chitarra e Giorgio con le nacchere brasiliane o con il cembalo, e intonavano quelle serenate struggenti alla "bella, meravigliosa la mia città". Erano cori che si acquietavano, piano piano, quando la notte non era più notte e una piccola striscia bianca stentava a annunciare il giorno. E per vederla bisognava spostarsi a Sant'Agostino quasi in punta di piedi.
Cesare sembrò poco e venne fuori anche Gianni. I suoi figli furono la colla d'innesto con il mondo della gioventù con il quale, del resto, faceva sempre racca perchè si sentiva giovane di dentro anche se gli anni passavano senza fargli troppo male, nè togliere un capello o scavare una piccola ruga. Il suo era un temperamento di quelli che se fossero in vendita farebbero la fortuna dello spacciatore. Ottimista, rigoglioso, non stava però ad aspettare la manna dal cielo. Quando aveva un'idea ci si baloccava, cercava di ravversarla per benino, restava in forse qualche tempo (perchè era un amante del perfezionismo fino allo scrupolo), eppoi si lanciava e allora nessuno gli teneva dietro. Fra tante cose che sapeva fare, fra le tante sue passioni, c'era la gastronomia. Divideva volentieri il fardello con Nirvano Fossi, tra una battuta e un'altra, tra un frizzo e un altro, e tirava fuori certi risultati che qualche locale rinomato davvero se li sognava (e se li sogna). Vennero fuori quasi per scherzo, tutti i due, quando cominciarono i lavori per la ristrutturazione di Castelsenio e tutta la cucina era in un paio di bracieri, qualche pentolona e il chiassino con il cielo per soffitto. Incominciarono allora i "venerdì". Alla fine di ogni serata, stanchi, sudati e allegri, si arrotolavano il grembiule alla bella maniera, si sedevano a un pinzo della lunga tavola, Nirvano con la chitarra e Giorgio con le nacchere brasiliane o con il cembalo, e intonavano quelle serenate struggenti alla "bella, meravigliosa la mia città". Erano cori che si acquietavano, piano piano, quando la notte non era più notte e una piccola striscia bianca stentava a annunciare il giorno. E per vederla bisognava spostarsi a Sant'Agostino quasi in punta di piedi.
Gli occhi brillavano, sorrideva sereno sotto i baffoni che si era fatto crescere forse per invecchiarsi perchè il viso restava ostinatamente giovanissimo, e sbirciava i suoi ragazzi, la sua "nidiata" che non sapeva brontolare con rabbia, che non sapeva redarguire senza un tocco di garbo. Tutti "suoi figlioli", perchè di loro sarà la Tartuca, "non ve lo ricordate che dicevano a noi i nostri babbi"? E si rivolgeva a Adù che scriveva i voti con il pennarello sulle magliette dell' "aggiungi un posto a tavola". Eppure ebbe a passare i suoi periodi di malattia e sofferenza, operazioni chirurgiche le vene che facevano bizze e "ostruzionismo", come lui senza prendersela diceva. E, da ultimo, anche il cuore che si imbizzarriva. Quando a Milano entrò nella sala operatoria, volle con sè il fazzoletto della Tartuca, sotto lo stretto materasso, e canticchiò l'inno fino a che gli occhi si chiusero nell'oblio. Dopo, il miracolo. Aveva potuto buttar via anche il bastone che per qualche anno lo aiutava nelle piccole passeggiate fra l' "uovo di Siena" (come chiamava Castelvecchio alla maniera di Wolfango Valsecchi) e l'angolo dell'unto. E aveva moltiplicato le recite nelle lunghe sere d'inverno, dopo aver dato vita a una stagione di cabaret con il meglio fra gli specialisti italiani. Faceva tutto da sè. Scriveva le commedie, consegnava le parti, componeva perfino le canzoni con la musica del suo amico Mikey, guidava la regìa, le prove, le luci, le scene, tutto. "Questi ragazzi si devono divertire", diceva. "Più che ai nostri tempi". "La Contrada è anche questo". "Eppoi si sentono più vicini e più amici". E Giorgio non mollava, un giorno dietro un altro, una stagione dietro un'altra. Manifesti, locandine, programmi lanciati e rilanciati anche in televisione casareccia, anche sulla cronaca. Il "Teatrino di Castelsenio" appariva più una palestra di allenamento per la comunità deì ragazzi che un'attività, sussiegosa. Come doveva essere. Cultura e tempo libero, come si dice oggi? No, meglio Contrada, che tutto comprende. A un certo punto anche i grandi non ebbero bene finchè non debuttarono. E si scroprirono i grandi attori, le dive, le graziose "show-girls", e una nuvola di aspiranti da quattro a trenta anni. Giorgio Civai era il pernio della ruota e su lui tutto girava tranquillo.
Poi scendeva, fazzoletto bianco al collo e "toc" in testa: tornava ad essere il "barone della cucina". Tegami, salse, coltelli (bisogna arrotarli, urlava!), sughi al bacio e panna gettata al centro della padella come i grandi "chef". "O nini, fai una corsa dal fruttivendolo e fatti dare gli odori che lui sa": e il ragazzino di turno partiva, lasciando per un momento i compagni con i tavoli in mano. Il lungo vicolo si riempiva, le tovaglie candide si aprivano, la striscia costellata di bottiglie arrivava fino alla stalla ed oltre. Lui si affaticava, sudava, qualche punta di dito scottava, qualche manciata di pepe in più, il volto sì arrossiva alla fiamma. Poi le immancabili arrabbiature: sessanta, ottanta, cento ospiti in più del previsto. "Perderebbe la pazienza anche Sant'Antonio" disse una sera Adù. Giorgio la perdeva per due minuti, poi la ritrovava subito. E gli ospiti non sapevano mai che c'erano tanti di più.
E' difficile tenere a mente gli incarichi che ebbe in Tartuca e quelli che gli piovevano addosso in Castelsenio dove fu anche Presidente passando poi la palla a Cesare, il figlio, e continuando imperterrito la sua quotidiana dedizione. Collaborava spesso a questo giornalino. Si può dire lo tenne a battesimo con Ugo Tallurì, Giordano Barbarulli e qualche altro. Scriveva meravigliosamente e, secondo il suo carattere, suscitava la risata con le sue "agopunture": il chè non è cosa facile. Poi tenne per due anni la Compagnia di Porta all'Arco e la risollevò dall'oblìo (lui che aveva vissuto i tempi d'oro) e stavolta era passato alla segreteria per la compilazione di lettere difficili e diplomatiche. Per la sera del sabato, alla festa titolare, era diventato lezzo perchè i ragazzi avevano messo male i tavoli lungo la strada ma pochi giorni dopo, alla cena della prova generale, era disteso e soddisfatto del bel lavoro di Robertino Burroni, dei suoi aiuti, delle care donne. Cantava e stornellava cercando di mettere una toppa agli stonati. E anche venerdì, 13 luglio, si trattenne con gli altri che non avevano voglia di lasciare il "chiassino", fino alle una e mezzo. Un'altra riunione a tavola, un'altra cena fra amici. Si sparpagliarono di fronte alla Chiesa e lui sparì dentro il portone con un "buona notte ragazzi" più squillante del solito.
Appena dieci ore, il brutto sogno, l'incubo. Giorgio Civai era morto. Qualcuno urlava, molti piangevano, la Chiesa si era aperta unicamente per lui. Venne Mauro Barni per la chiusura della cassa, per l'annuncio sul giornale. Tornarono in molti dal mare, dalle ferie. Ogni momento arrivavano fiori, tanti fiori che lo circondarono, quasi lo soffocarono. Una moltitudine di gente inebetita, incredula, vagante. Tutti allo sbando a chiedersi se era vero, se era questa la vita, e se lo era perchè non organizziamo meglio i nostri giorni, perchè non ci vogliamo più bene, perchè ci pensiamo solo dopo, facendo sempre un male più grande per schiacciare quello più piccolo. La gente ripeteva con estenuante balbettìo le frasi inconcludenti e soffocanti che stanno ai bordi della grande verità. Ma di certo era solo un brutto sogno. Accarezzammo in molti questa ipotesi remota e, minuto dopo minuto, incominciammo a persuaderci. Infatti Giorgio Civai continuava a sorridere in ogni posto abituale. Continuava a scrivere qualcosa, a buttar giù un progettino, a riaprire la cucina di Castelsenio, ad arrotare un lungo coltello, a intonare un nuovissimo motivo. Era lì, dietro le bandiere a fascio nel salone, che parlava con qualcuno che poteva anche essere Nirvano.
Giulio Pepi (da Murella Cronache)
foto: in alto Giorgio Civai negli anni '60 a Castelsenio con Danilo Pepi; sotto, Giorgio al Chiesino dei Tufi nel giugno degli anni '80